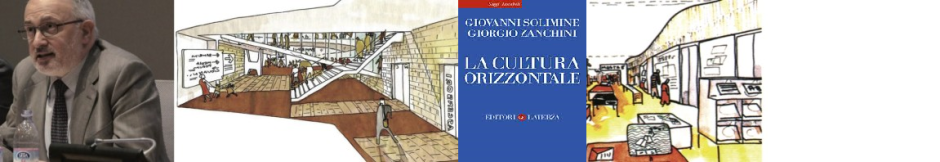Si è svolto ieri ed oggi a Milano il convegno delle Stelline, che da circa un ventennio è diventato l’evento più importante per il mondo delle biblioteche. Il tema di quest’anno era “La biblioteca aperta: tecniche e strategie di condivisione”. Segnalo in particolare la sessione di ieri pomeriggio, che ho avuto modo di coordinare e durante la quale si è discusso del ruolo della biblioteca pubblica nelle politiche di welfare e degli strumenti per la valutazione dell’impatto sociale delle biblioteche. Sullo sfondo, ovviamente, le riflessioni in atto sull’identità e sulla crisi della biblioteca pubblica contemporanea: cos’è oggi, cosa vorrà e cosa potrà essere in futuro. Il link col welfare nasce dalla convinzione del ruolo infrastrutturale delle biblioteche ‒ al di là del compito specifico di accesso alla conoscenza ‒ nella lotta per il superamento delle disuguaglianze, per favorire l’inclusione sociale e la partecipazione, intese come strumenti per esercitare i diritti di cittadinanza. L’occasione di incontro che ci ha visto riuniti nasce proprio all’insegna di questa prospettiva, come dimostra la complementarità dei relatori, caratterizzati da profili e sensibilità molto differenti. Si è partiti da una riflessione strettamente biblioteconomica: Giovanni Di Domenico, docente all’Università di Salerno, nel suo contributo (Funzione sociale e valore delle biblioteche pubbliche: alcuni riscontri recenti della valutazione d’impatto in campo internazionale) ha messo in evidenza come negli ultimi anni la valutazione dell’impatto sociale delle biblioteche pubbliche abbia prodotto una buona massa critica di studi, dati e riflessioni, con l’obiettivo di riposizionare le biblioteche stesse nei processi della riproduzione sociale al tempo della crisi e ha passato in rassegna i diversi approcci metodologici e i filoni indagati: la sfida consiste nel passare dalla valutazione degli outputs alla valutazione degli outcomes. L’intervento di Chiara Faggiolani, ricercatrice alla Sapienza di Roma, («Ciò che misuriamo influenza ciò che facciamo». Una nuova stagione per la valutazione in biblioteca pensando al BES) ha proseguito il ragionamento sulle biblioteche, entrando all’interno degli strumenti di rilevazione della statistica ufficiale per osservare i dati che vengono prodotti sulla domanda di servizi bibliotecari. Alla luce della crescente importanza attribuita all’analisi dei dati nel processo decisionale, ha individuato alcuni passaggi da seguire per una nuova stagione per le attività di valutazione in biblioteca all’insegna di una più stringente collaborazione con la statistica ufficiale. Il rapporto annuale sul “Benessere equo e sostenibile” (BES) prodotto dall’Istat viene individuato come punto di arrivo e viene sottolineata l’importanza che rivestirebbe la presenza di indicatori sui servizi bibliotecari all’interno delle diverse dimensioni con cui viene misurato il benessere. Il focus si è ampliato, passando dalle biblioteche alle attività culturali in generale, con la relazione di Alessandra Gariboldi della Fondazione Fitzcarraldo di Torino (Le sfide aperte della misurazione degli impatti delle attività culturali), che ha messo in evidenza le implicazioni anche di carattere politico delle attività di valutazione: chi deve misurare e che cosa? Quali tipi di impatti possono essere considerati rilevanti? A cosa serve la valutazione? Queste alcune delle domande alle quali la sua riflessione ha cercato di dare una risposta, sottolineando le potenzialità che le biblioteche ‒ per la loro capillare diffusione sul territorio e per la sensibilità che storicamente hanno maturato nei confronti di questi temi ‒ possono avere in quest’ambito. Alessandra Federici, ricercatrice dell’Istat, ha presentato nel suo intervento (Mappatura del patrimonio librario in Italia: modelli di indagine per la rilevazione delle biblioteche diffuse sul territorio nazionale) una prima ipotesi di indagine ‒ che l’Istituto nazionale di statistica sta progettando in collaborazione con la Sapienza ‒ per conoscere più da vicino la realtà dei servizi bibliotecari in Italia. Sono stati delineati obiettivi, metodologie e fasi di una ricerca che andrà impostata e condotta in modo partecipato e coinvolgendo i diversi soggetti che sono titolari di competenze in materia di biblioteche. In linea con la visione delle biblioteche pubbliche come istituti del welfare con un raggio d’azione assai ampio, in grado di incidere direttamente su aspetti molto importanti della vita individuale e collettiva delle persone, Stefano Cima nella sua relazione (Biblioteche sociali. Strumenti per la progettazione e la valutazione) ha proposto un approfondimento sull’importante esperienza maturata nella valutazione degli effetti dei progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo e finalizzati a creare coesione sociale attraverso le biblioteche. Infine, Anna Galluzzi, studiosa che ha dedicato molti studi all’evoluzione delle biblioteche pubbliche nei diversi contesti territoriali, ha approfondito col suo intervento (Biblioteche pubbliche, welfare e democrazia: sulle tracce di un rapporto difficile) la complessità del rapporto tra biblioteche pubbliche, welfare e democrazia. A tal fine ha riportato l’esperienza della “Public Library Inquiry”, uno studio condotto in USA negli anni ’40 del secolo scorso che doveva valutare in termini sociologici, culturali e umani fino a che punto le biblioteche stessero raggiungendo i loro obiettivi e quale fosse il loro contributo attuale e potenziale alla società americana. Ne è emersa un’impressionante similitudine con i temi attualmente in discussione, a riprova di quanto sarebbe utile conoscere più di vicino lo slittamento di paradigma cui stiamo assistendo e valutare quali effetti vengono prodotti oggi dalle biblioteche pubbliche italiane. Il momento di discussione che abbiamo promosso si è proposto, dunque, di stimolare una nuova consapevolezza sulla necessità di costruire percorsi che mirino a monitorare sistematicamente il ruolo delle biblioteche come agenti di coesione sociale e per il benessere dei cittadini. Il potenziamento e il riconoscimento di questo ruolo potrebbe far uscire i servizi bibliotecari di base dalla loro attuale condizione di marginalità e accreditarli come una componente importante del tessuto connettivo del Paese.